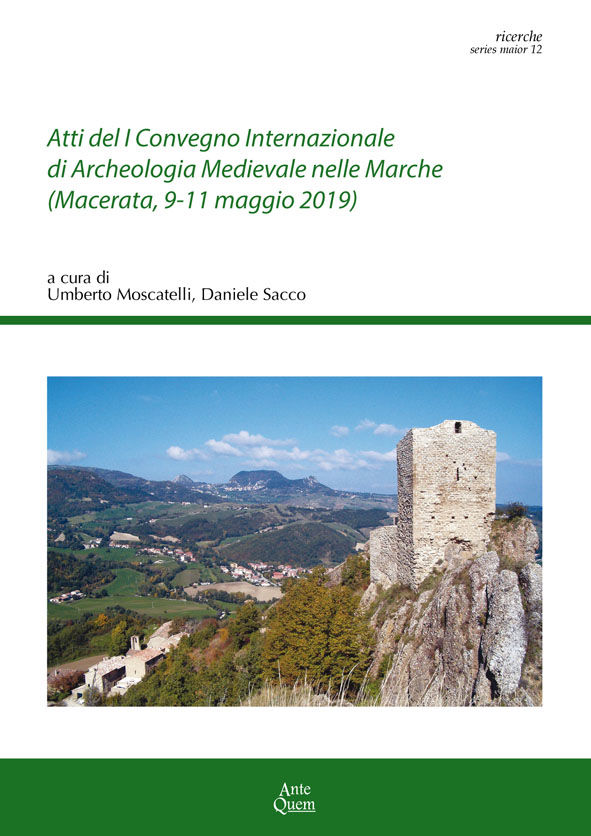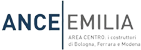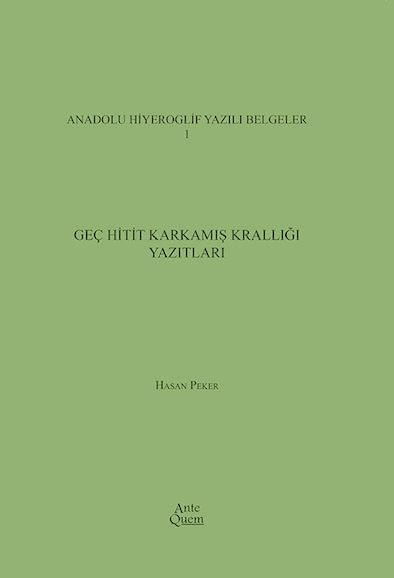
GEÇ HİTİT KARKAMIŞ KRALLIĞI YAZITLARI
ISBN 978-88-7849-178-6
ISBN 978-88-7849-181-6 (pdf)
© Ante Quem 2022
120 pagine b/n
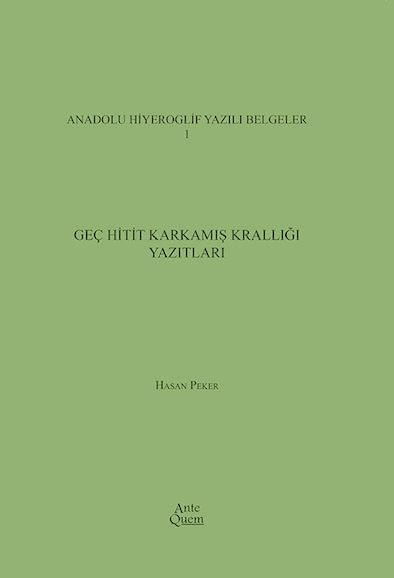
ISBN 978-88-7849-178-6
ISBN 978-88-7849-181-6 (pdf)
© Ante Quem 2022
120 pagine b/n

600 a.C. Bologna – Felsina per gli antichi – è una delle più ricche e sviluppate città d’Italia e del Continente. Nel secolo detto “dell’orientalizzante”, per il grande sfoggio di oggetti e costumi mutuati dal Vicino Oriente che furoreggia fra le elites di tutto il Mediterraneo, la città è un punto di riferimento culturale per l’intero arco alpino centro-orientale. Qui erano già giunti maestri dalla Siria e da altre zone del Levante, abili in un campo nel quale da millenni ormai in Europa si era persa quasi ogni cognizione: l’arte figurativa. Ecco allora che a Felsina – da immaginare quasi come una Firenze ante litteram – assieme a una ricca serie di stele in pietra che adornano i sepolcreti cittadini, nasce l’Arte delle situle, una produzione di manufatti figurati in bronzo destinata ad affermarsi in tutto il bacino altoadriatico. Rinvenuta nel 1870 da Alessandro Zannoni durante gli scavi della necropoli bolognese della Certosa, la situla, assieme alla Benvenuti 126 di Este, è il capolavoro di quest’arte. La narrazione, realizzata a sbalzo e ad incisione sulle pareti del vaso, è un testo complesso che, seppur già studiato e soprattutto citato un’infinità di volte, a 150 anni dalla sua edizione risulta in letteratura criptico e perlopiù indecifrato. Lo studio presentato in questo volume, utilizzando lo stesso metodo usato con la situla Benvenuti, dimostra invece come ci si trovi di fronte ad un’architettura altamente sofisticata nella quale ogni singolo segno ha un suo preciso posto e una sua precisa funzione, a formare un quadro d’insieme dotato di significato chiaro e coerente. Dalla maggior parte degli studiosi ritenuta un’opera a carattere funerario, la situla e la sua narrazione figurata vengono invece qui letti come estesa rappresentazione dell’antico rito delle genti etrusco-italiche: quello noto come suovetaurilia e che prevedeva la circumambulazione dei confini civici e il compimento di sacrifici di tori, ovicaprini e suini. Del tutto sorprendenti le analogie, ampiamente approfondite dall’Autore, fra il racconto figurato e le Tavole di Gubbio, «la più importante serie di testi scritti di carattere religioso e rituale dell’antichità greco-romana», come le ha definite G. Devoto, fonti preziosissime per raccontarci la mentalità religiosa dell’epoca e soprattutto la ritualità etruscoitalica. Totalmente innovativa, infine, la lettura in chiave geografica e astronomica di alcune parti, che mette in luce una dimensione finora totalmente sconosciuta (o misconosciuta) di quest’opera, ma anche dell’intera Arte delle situle: quella che lega insieme ed esprime, in forma precisa e chiara, lo spazio e il tempo del racconto.
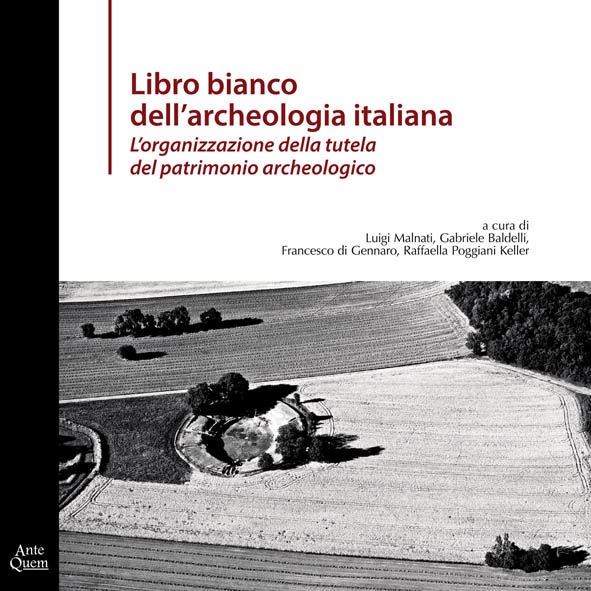
ed. Ante Quem 2022
pp. 180
ISBN 978-88-7849-172-4
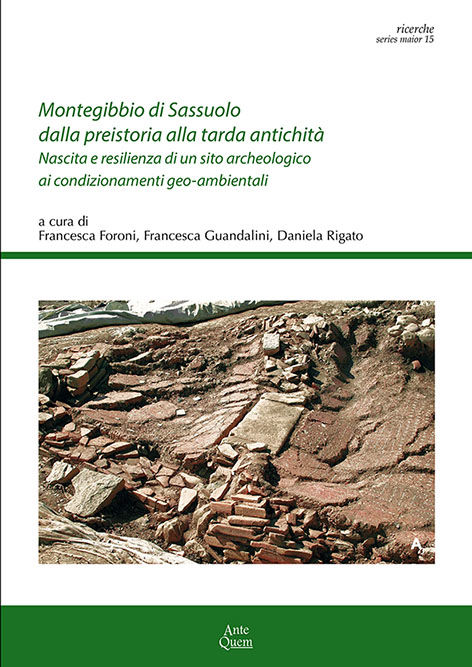
Nella zona collinare alle spalle di Sassuolo, presso Montegibbio, la presenza di un’area caratterizzata da piccoli vulcani di fango di colore insolito ha rappresentato l’elemento di attrazione per una frequentazione di natura eminentemente religiosa, dalla preistoria fino alla tarda antichità. Il sito archeologico, con il suo santuario dedicato a Minerva, viene presentato in questo volume dopo una serie multidisciplinare di studi, che hanno fornito diversi piani di lettura e che sono il frutto di una sinergia, sul campo e nella successiva fase di edizione dei dati, di numerose figure professionali: hanno infatti collaborato a tali indagini esperti di archeologia, geologia, numismatica, epigrafia, archeobotanica, archeozoologia e litologia. Dal 2006 al 2015 lo scavo archeologico è rimasto aperto al pubblico e i risultati delle campagne di studio condotte sono presentati in questo volume privilegiando la concretezza dei dettagli di scavo.
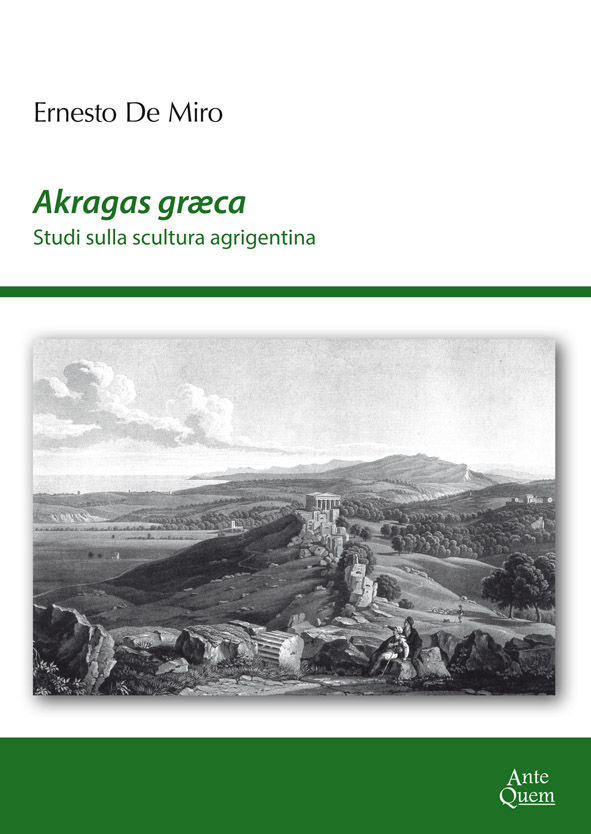
È noto che Akragas, fra le più importanti colonie greche di Sicilia, abbia svolto un ruolo determinante in campo politico, sociale, e fornito pregevoli testimonianze artistiche. A supporto di questa affermazione valgono le numerose sculture prodotte in loco o importate – su cui è incentrata la prima parte del volume –, che hanno notevolmente influenzato la cultura classica occidentale. Tutte le sculture in oggetto, in gran parte esposte nel Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, sono accompagnate da un commento critico, che sovente riporta alle principali correnti artistiche della Grecia e ai suoi influssi sulle realtà locali. Il tempio di Zeus Olympio di Agrigento – su cui si focalizza la seconda parte – è stato oggetto di continue attenzioni nel corso del tempo, volte a leggere fra le rovine elementi significativi per una completa comprensione. Questo studio ripercorre in termini essenziali la sua bibliografia, sulle cui premesse si è voluto affrontare il tema, non mai precisato, della strategia progettuale figurativa del grande tempio. Su tal via si riprende in una nuova luce il problema delle raffigurazioni frontonali con una rilettura del testo diodoreo relativo alle stoai. Infine, non conoscendosi il nome dell’autore del progetto figurativo, si propone di coglierne l’ispiratore su indizi documentari nel poeta Pindaro, ascoltato ospite alla corte di Terone.